





ORGANI DI SENSO
LA VISTA
La vista è una funzione presente e attiva in tutti gli ofidi ad eccezione degli scavatori. La retina dell'occhio della maggior parte delle specie possiede coni e bastoni, per cui possono vedere colori sotto la luce del sole e unicamente toni di grigio in condizioni di scarsa illuminazione. La posizione degli occhi assicura una visione binoculare in un campo che va dai 30 ai 45°, capace di discernere la distanza alla quale si trovano gli oggetti.


L'occhio degli ofidi possiede capacità di focalizzare le immagini grazie all'azione dei muscoli ciliari che esercitano una pressione sopra l'umor vitreo che spinge gradualmente fino al fronte del cristallino fino ad avere nitida l'immagine nella retina. La pupilla generalmente rotonda, può contrarsi fino a formare una struttura allungata che regola la quantità di luce che entra nella retina.
La struttura dell'occhio negli ofidi varia in funzione al tipo di vita del serpente (terrestre, acquatica, arboricola) così come dalle sue abitudini diurne, notturne o crepuscolari. Ciò porta ad avere una gamma di varianti tra pupilla verticale o circolare e nella proporzione dei coni e bastoni.
Il nervo ottico parte dalla retina, attraversa lo sclera, si incrocia nel chiasma ottico e raggiunge il cervello alla base, di fronte alla ghiandola pituitaria.
L'occhio presenta anche una ghiandola congiuntiva conosciuta come "ghiandola di Harder", ubicata nella base dell'occhio in posizione anteriore all'inserzione del nervo ottico. L'occhio è protetto da una lente epidermica trasparente formata dalla fusione delle palpebre.
L'UDITO
L'orecchio degli ofidi, così come il tatto, è rudimentale e poco utilizzato essendo poco evoluto o molto ridotto. I serpenti mancano di di orecchio esterno e l'orecchio medio è rappresentato unica,mente dalla staffa. Questa è un ossicino di forma allungata che nel suo estremo esterno fa contatto con l'osso quadrato, mentre nel suo estremo interno penetra la finestra ovale e la pone in contatto con la perilinfa dell'orecchio interno molto vicino alla papilla basale del canale cocleare.
La papilla basale è la responsabile dell'udito e consiste in una membrana che reagisce alle vibrazioni. Per questa ragione l'orecchio dei serpenti risponde alle vibrazioni trasmesse dalle ossa della mandibola inferiore (quadrato e articolare) e in minor misura a quelle della mandibola superiore. Perchè le vibrazioni raggiungano la mandibola inferiore è indispensabile che il serpente mantenga la testa in contatto con il substrato e che la vibrazione sia forte perchè possa essere recepita. Ciò impedisce l'audizione di suoni che si trasmettono per l'aria. Tuttavia esiste la possibilità che e squame che ricoprono la pelle nella zona temporale siano coinvolte in qualche modo alla percezione dei suoni, particolarmente nei serpenti arboricoli.
L'organo vestibolare , responsabile dell'equilibrio, è costituito da canali semicircolari, l'utricolo e il sacculo, ubicati dentro l'orecchio interno.
IL TATTO

Il senso del tatto non è molto sviluppato nei serpenti, probabilmente per la natura chitinosa della parte esteriore della pelle che si muta e si rinnova periodicamente. I serpenti possiedono un gran numero di corpuscoli tattili sotto le squame, tuttavia sono quasi insensibili al calore, al dolore e alla pressione.
Il senso più sviluppato, perfezionato ed evoluto negli ofidi è la chemorecezione (capacità di ricevere messaggi chimici dall'ambiente circostante) cui sono incaricati il senso dell'olfatto e l'organo vomero nasale o di Jacobson. Entrambe però sono completamente differenti tanto nella natura dello stimolo come nella loro innervazione.
L'olfatto termina nelle fosse nasali, rivestite da un epitelio sensibile ben sviluppato, le fosse nasali si aprono all'esterno, dorsalmente nel muso e terminano nel tetto della parte media del palato, dentro la bocca del serpente.
L'olfatto è sensibile a sostanze volatili che sono captate direttamente dall'aria inspirando, le quali si addossano all'epitelio sensoriale della camera principale. L'aria continua il suo passaggio per tutta la fossa nasale fino alla bocca.
ORGANO DI JACOBSON
L'organo vomero nasale presente negli altri vertebrati mostra il suo massimo sviluppo negli ofidi.
Si differenzia dall'olfatto per i centri nervosi a cui è associato e per essere sensibile a sostanze non volatili che raggiungono l'epitelio sensoriale attraverso la lingua.
E' un organo sensoriale extra del palato che accentua l'olfatto e consiste di due strutture a sacco vuoto molto sensibili.

L'organo di Jacobson è un epitelio sensoriale alloggiato all'interno di una cavità ubicata nella parte anteriore del palato dentro il canale olfattivo e comunica con la lingua attraverso un'apertura a solco situata nel tetto della cavità orale, nella quale incastra l'epiglottide quando la bocca è chiusa. La lingua è bifida e retrattile e trattiene particelle non volatili dell'aria e substrato.
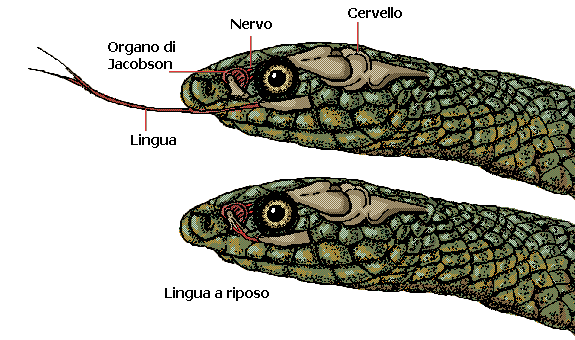
Mediante un fine condotto l'organo vomeronasale capta le molecole e sensazioni chimiche raccolte dalla lingua quando viene estratta, che vengono portate a cellule sensitive situate internamente le quali processano le informazioni al cervello.
La lingua costituisce quindi un organo molto importante nella vita degli ofidi, per questo motivo quando sono a riposo è retratta all'interno di una profonda cornea che la protegge. La lingua è sommariamente protrattile e il serpente la proietta ripetutamente anche quando la bocca è chiusa; ciò è possibile tramite una fenditura nel bordo anteriore della mandibola superiore. Lo sviluppo dell'organo di Jacobson è tanto importante in alcuni serpenti che la dimensione del bulbo vomeronasale può essere maggiore di quella del bulbo olfattivo.
FOSSE TERMORECETTRICI
Un sistema esclusivo di alcuni ofidi è il responsabile della percezione di energia calda con lunghezze di onde infrarosse mediante organi specializzati conosciuti come fosse termorecettrici. La loro localizzazione varia in funzione del gruppo tassonomico dei serpenti che lo possiedono. I crotalidi (Crotalinae) possiedono un paio di fosse che si localizzano nella zona tra l'orifizio nasale e l'occhio.

Nella famiglia Boidae il loro numero è maggiore e si localizzano dentro le squame delle labbra della mandibola inferiore e superiore. Alcuni boa hanno le fossette coperte da squame mentre i pitoni e boa arboricoli del genere Epicrates sono piuttosto grandi e si osservano con facilità. la struttura della fossa è simile in tutti i gruppi; consta di un orifizio o apertura che comunica a una cavità generalmente più grande dell'orifizio. La cavità è profonda ed è divisa da una sottile membrana in due parti, formando una cavità esterna ed una interna. La membrana è molto innervata da due rami del nervo trigemino. Le terminazioni nervose della membrana mancano della copertura di mielina e sono sature di mitocondri i quali cambiano di forma al ricevimento di uno stimolo infrarosso per cui costituiscono il recettore di calore primario.
La sensibilità di queste fossette è da 0.0019 a 0.0034 calorie per centimetro quadrato, molto superiore a quella ottenuta dai sensori fabbricati dall'uomo. Il loro numero e la loro posizione nei crotalidi assomiglia al funzionamento degli occhi nei vertebrati. Permettono di conoscere l'ubicazione e la distanza alla quale si trova la fonte di calore, utile soprattutto di notte per la cattura delle prede.