





PELLE

La pelle dei serpenti è molto simile a quella dei sauri per cui entrambi si raggruppano nell'ordine Squamata (squamati). La pelle è relativamente impermeabile, con squame epidermiche di cheratina, con pigmenti, senza ghiandole o con ghiandole olocrine ( la cellula ghiandolare viene espulsa con la loro secrezione),può formare scudi ossei, ha valore tassonomico ed è costituita da epidermide, derma e ipoderma.
E' piuttosto impermeabile in quasi tutti i gruppi, anche se esistono specie di pelle molto sottile e delicata che possono perdere quantità considerevoli di acqua, specialmente in quelle specie la cui zona presenta una umidità atmosferica alta. La relativa impermeabilità all'acqua è prodotta dallo strato di cheratina e cellule morte che costituiscono la parte più esterna della pelle.
L'epidermide in generale non è irrigata e presenta poca innervazione, non possiede pigmenti, il suo colore scuro semitrasparente lo conferisce la cheratina, è di origine ectodermico ed è costituita da quattro strati cellulari sovrapposti. Sulla parte più esterna si presenta il primo strato con una cuticola che scompone la luce, formato da cheratina e cellule epidermiche morte che si rinnova periodicamente, generalmente in un solo pezzo.

Questo primo strato di epidermide presenta ingrossamenti costituiti principalmente di cheratina, le squame.
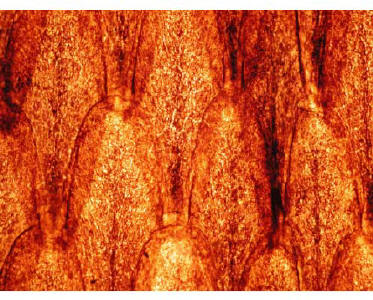
A differenza di quelle dei pesci , le squame dei rettili sono strutture molto differenti e di distinta origine embrionaria; le squame dei pesci sono dermiche, mentre quelle dei rettili sono epidermiche e di origine ectodermica. Ciò comporta severe ripercussioni dato che le squame dei rettili si rinnovano costantemente, il che non succede nei pesci. E sebbene entrambi facilitino lo spostamento riducendo la frizione con l'ambiente, le squame dei serpenti non si sovrappongono tanto facilmente come quelle dei pesci.
All'interno delle squame esiste una zona di epidermide "nuda" chiamata "zona di articolazione", che permette che le squame si distendano, facendo della pelle dei serpenti una struttura flessibile ed elastica, non rigida come quella dei pesci.
Il secondo strato dell'epidermide è corneo, ed è responsabile della colorazione iridescente della pelle di alcune specie, nelle quali, in certe angolazioni, l'incidenza della luce si scompone mostrando un arco iridescente.

Il terzo strato (zona intermedia) presenta "polpastrelli" tattili in scarsa quantità in tal modo che la pelle sia vulnerabile a danni fisici come traumi o bruciature gravi, senza che il serpente lo percepisca. Per questo non è raro che si incontrino serpenti silvestri con grandi ferite nelle pelle o morsicature di animali che possono perforare completamente la pelle senza che apparentemente ciò infastidisca l'animale.
Per chi mantiene serpenti in cattività le relativa insensibilità che mostrano gli esemplari nella pelle deve essere tenuta in considerazione riguardo la fonte di calore nel terrario; se la temperatura superficiale di tale fonte di calore supera i 50° C il serpente può subire scottature di terzo grado mentre è intento a scaldarsi.
Lo strato più profondo dell'epidermide è il quarto strato, strato basale, costituito da una fila di cellule che rinnovano gli strati superiori.
Il derma si origina nel mesodermo embrionario, è innervato e irrigato, formato da tessuto congiuntivo, presenta fibre di tessuto muscolare liscio ed è ricco di collagene e contiene pigmenti chiamati cromatofori, di cui i principali sono la melanina e la guanina. Combinandosi tra di loro i pigmenti e interagendo con lo stato glutinoso superficiale, producono la gamma di toni del corpo dei serpenti.
I melanofori sono responsabili dei toni scuri: i melanofori in combinazione con i guanofori producono i toni grigi, in combinazione con i guanofori e lipofori producono i toni verdi e gialli mentre in combinazione con guanofori e alofori producono toni rosso scuro.
La colorazione nella pelle dei serpenti è generalmente criptica è "umocromica" con l'ambiente in cui vivono, il che permette all'animale di passare inosservato tanto a predatori come a potenziali prede.

I toni scuri aiutano la simulazione per i serpenti terrestri mentre quelli arboricoli con tonalità verdi sono praticamente invisibili nel fogliame. In pochi gruppi la colorazione è aposematica (aiuta il serpente ad evidenziare la sua pericolosità), cosa che un maggior numero di serpenti inoffensivi spesso mostrano. Questa colorazione , chiamata anche "di avvertimento", è evidente nei corallini (Micrurus e Micruroides) così come nei falsi coralli (Lampropeltis, Pliosercus e Rhinocheilus).

In poche specie si presenta dicromismo sessuale (differenza di colore tra il maschio e la femmina) di cui il Crotalus lepidus klauberi ne è un buon esempio; i maschi sono verdi mentre le femmine grigie.
A differenza degli anfibi e mammiferi, il derma dei rettili è carente di ghiandole,incluse le sudoripare. Ragione per cui la pelle dei serpenti, e quella dei rettili in generale, è secca e pulita. Le poche ghiandole che si trovano nella pelle degli ofidi sono di tipo olocrino, come le ghiandole sebacee dei mammiferi, che non sono vascolarizzate.
La zona più profonda della pelle dei serpenti è l'ipoderma, che in minima proporzione accumula riserve adipose, principalmente nella zona caudale; anche se i corpi grassi più importanti degli ofidi si localizzano nella parte ventrale della zona addominale.
La disposizione e il numero delle squame nei serpenti ha molte piccole variazioni che vengono utilizzate come carattere diagnostico nella classificazione.
La lepisosis, disturbo della pelle che si squama, è la base principale delle chiavi tassonomiche che permettono la differenziazione delle specie. In base a tale principio, si conferisce un nome ad ogni squama della testa e si "zonificano" quelle delle altre parti del corpo.

In un gran numero di serpenti la pelle della parte superiore della regione cefalica si presenta unita direttamente alle ossa del cranio e senza tessuto all'interno, presentando in alcuni gruppi grandi squame o scudi.
Quasi tutti i serpenti mostrano squame ventrali allungate trasversalmente in relazione diretta alle costole. La presenza di queste squame ventrali allungate è un carattere differenziale nei serpenti e negli apodi. Nei serpenti arboricoli e nei costrittori, le squame ventrali sono meno ampie rispetto a quelle dei terrestri o corridori. Tale disegno più compatto concentra in una minor superficie la forza con la quale i serpenti si afferrano ad un ramo o si arrotolano sopra una preda.
La pelle dei serpenti, come in tutti i rettili, può presentare strutture dermiche simili a cornetti, ingrossamenti della pelle e strutture più complesse come l'organo corneo dei generi Crotalus e Sistrurus che mostrano la parte finale della coda a sonaglio.

Il sonaglio è una secrezione cornea prodotta da ghiandole localizzate nella base. La forma è conica e ricopre la parte finale della coda e presenta più segmenti. Ogni segmento è prodotto ad ogni muta della pelle; per cui ogni volta che il serpente muta la pelle, si aggrega un segmento nuovo nella base della coda. Quando il serpente fa vibrare la coda i segmenti si scontrano fra di loro producendo il caratteristico suono. Tale vibrazione è favorita dalla fusione delle ultime vertebre della coda; i segmenti del sonaglio sono delicati e fragili e si rompono con facilità, principalmente quando ne sono presenti parecchi.

E' raro incontrare in natura serpenti con più di sei o sette segmenti; in condizioni di cattività, essendo meno esposti a fattori di "disturbo"(rocce, tronchi...) che possono provocare la rottura del sonaglio, è possibile trovare esemplari con sonagli di anche 15 segmenti o più.
| R e t t i l i | A n f i b i | P e s c i | A r a c n i d i | C u r i o s i t à | P i a n t e | T e r r a r i A c q u a r i |